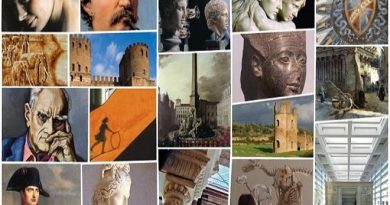Seconda Predica di Avvento, del Predicatore della Casa Pontificia, Card. Raniero Cantalamessa
Alle ore 9.00 di questa mattina, nell’Aula Paolo VI, il Predicatore della Casa Pontificia, Card. Raniero Cantalamessa, ha tenuto la seconda Predica di Avvento sul tema: “Sollevate, porte, i vostri frontali” (Sal 24, 7-8). Fede, Speranza e Carità: le tre porte da aprire a Cristo che viene.
La successiva e ultima predica di Avvento avrà luogo venerdì 16 dicembre.
Di seguito il testo della Seconda Predica di Avvento del Predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa
LA PORTA DELLA SPERANZA
In attesa della beata speranza
“Sollevate, porte, i vostri frontali, apritevi, porte antiche, ed entri il re della gloria” (Sal 24, 7). Abbiamo preso questo versetto del salmo come filo conduttore delle meditazioni di Avvento, intendendo per le porte da aprire quelle delle virtù teologali: fede, speranza e carità. Il tempio di Gerusalemme –leggiamo negli Atti degli apostoli – aveva una porta chiamata “la Porta Bella” (At 3, 2). Il tempio di Dio che è il nostro cuore ha anch’esso una porta “bella”, ed è la porta della speranza. È questa la porta che oggi vogliamo cercare di aprire a Cristo che viene.
Qual è l’oggetto proprio della “beata speranza”, di cui a ogni Messa proclamiamo di essere “in attesa”? Per renderci conto della novità assoluta recata da Cristo in questo campo, bisogna collocare la rivelazione evangelica sullo sfondo delle credenze antiche sull’aldilà.
Su questo punto, anche l’Antico Testamento non aveva alcuna risposta da dare. È risaputo che solo verso la fine di esso si ha qualche affermazione esplicita su una vita dopo la morte. Prima di allora, la credenza d’Israele non differiva da quella dei popoli vicini, specialmente di quelli della Mesopotamia. La morte pone fine per sempre alla vita; si finisce tutti, buoni e cattivi, in una specie di lugubre “fossa comune” che altrove si chiama Arallu e nella Bibbia lo Sheol. Non diversa è la credenza dominante nel mondo greco-romano contemporaneo del Nuovo Testamento. Esso chiama quel triste luogo di ombre Inferi, o Ade.
La cosa grande che distingue Israele da tutti gli altri popoli è che esso ha continuato, nonostante tutto, a credere nella bontà e nell’amore del suo Dio. Non ha attribuito la morte, come facevano i babilonesi, all’invidia della divinità che riserva solo per sé l’immortalità, ma piuttosto al peccato dell’uomo (Gen 3), o semplicemente alla propria natura mortale. In certi momenti, l’uomo biblico non ha taciuto, è vero, il proprio sconcerto di fronte a una sorte che sembrava non fare alcuna distinzione tra giusti e peccatori. Mai, tuttavia, Israele è giunto alla ribellione. In alcuni oranti biblici, esso sembra essersi spinto fino a desiderare e intravvedere la possibilità di un rapporto con Dio oltre la morte: un essere “strappato dagli inferi” (Sal 49,16), “stare con Dio sempre” (Sal 73, 23) e “saziarsi di gioia alla sua presenza” (Sal 16, 11).
Quando, verso la fine dell’Antico Testamento, questa attesa, maturata nel sottosuolo dell’anima biblica, verrà finalmente alla luce, non si esprime, alla maniera dei filosofi greci, come sopravvivenza dell’anima immortale che, liberata dal corpo, torna al mondo celeste da cui proviene. In armonia con la concezione biblica dell’uomo, come unità inseparabile di anima e corpo, la sopravvivenza consiste nella risurrezione – corpo e anima – dalla morte (Dan 12, 2-3; 2 Macc 7, 9).
Gesù ha portato, di colpo, al suo meriggio questa certezza e – quello che più conta – dopo averla annunciata in parabole e detti (come quello in risposta ai Sadducei sulla donna moglie di sette mariti: Mt 22,30) – ne ha dato la prova irrefutabile risorgendo lui stesso da morte. Dopo di lui, per il credente, la morte non è più un atterraggio, ma un decollo!
Il dono più bello e l’eredità più preziosa che la regina d’Inghilterra Elisabetta II, ha lasciato alla sua nazione e al mondo, dopo 70 anni di regno, è stata la sua speranza cristiana nella risurrezione dei morti. Nel rito funebre, seguito dal vivo da quasi tutti i potenti della terra e, per televisione, da centinaia di milioni di persone, furono proclamate, per sua espressa volontà, nella prima lettura, le seguenti parole di Paolo:
La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo (1 Cor 15, 54-57)
E, nel Vangelo, sempre per sua volontà, le parole di Gesù:
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore… Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. (Gv 14, 2-3)
La speranza, virtù operativa
Proprio perché siamo ancora immersi nel tempo e nello spazio, ci mancano le categorie necessarie per rappresentarci in che cosa consista questa “vita eterna” con Dio. È come tentare di spiegare cos’è la luce a uno che è nato cieco. San Paolo si limita a dire:
Si semina ignobile e risorge glorioso,
si semina debole e risorge pieno di forza;
si semina un corpo animale,
risorge corpo spirituale (1 Cor 15, 43-44).
Ad alcuni mistici è stato dato di sperimentare, fin da questa vita, qualche goccia dell’oceano infinito di gioia che Dio tiene preparato per i suoi; ma tutti unanimemente affermano che non se ne può dire nulla con parole umane. Il primo di essi è lui stesso, l’apostolo Paolo. Egli confida ai Corinzi, di essere stato rapito, quattordici anni prima, al “terzo cielo”, in paradiso, e di aver udito “parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare”. (2 Cor 12, 2-4). Il ricordo che quella esperienza ha lasciato in lui è percepibile in ciò che scrive in altra occasione:
Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano (1 Cor 2,9).
Ma lasciamo da parte quello che sarà nell’aldilà (su cui possiamo dire così poco) e veniamo invece all’oggi della nostra vita. Riflettere sulla speranza cristiana significa riflettere sul senso ultimo della nostra esistenza. Una cosa è comune a tutti, a questo proposito: l’anelito e vivere “bene”. Appena però si cerca di capire cosa si intende per “bene”, si prospettano subito due classi di persone: quelle che pensano solo al bene materiale e personale e quelle che pensano anche al bene morale e di tutti, il cosiddetto “bene comune”.
Riguardo ai primi, il mondo non è cambiato molto dal tempo di Isaia e di san Paolo. Entrambi riportano il detto che correva ai loro tempi: “Mangiamo e beviamo perché domani moriremo” (Is 22, 13; 1 Cor 15, 32). Più interessante è cercare di capire quelli che si propongono –almeno come ideale – di “vivere bene” non solo materialmente e individualmente, ma anche moralmente e insieme con gli altri. Esistono dei siti in internet in cui si intervistano persone anziane su come, giunte al tramonto, valutano la vita che hanno vissuto. Sono, in genere, uomini e donne che hanno vissuto una vita ricca e dignitosa, a servizio della famiglia, della cultura e della società, ma senza alcun riferimento religioso. È patetico il tentativo di far credere che si è felici di aver vissuto così. La tristezza di aver vissuto – e fra breve non vivere più! -, nascosta dalle parole, gridava dagli occhi.
Sant’Agostino ha espresso il nocciolo del problema: “A che serve vivere bene, se non è dato vivere sempre?” . Prima di lui, Gesú aveva detto: “Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la sua vita?” (Lc 9, 25). Ecco dove si inserisce – e in che cosa differisce – la risposta della speranza teologale. Essa ci assicura che Dio ci ha creati per la vita, non per la morte; che Gesú è venuto a rivelarci la vita eterna e darcene la garanzia con la sua risurrezione.
Una cosa si deve sottolineare per non cadere in un pericoloso equivoco. Vivere “sempre” non si oppone al vivere “bene”. La speranza della vita eterna è ciò che rende bella, o almeno accettabile, anche la vita presente. Tutti, in questa vita, abbiamo la nostra parte di croce, credenti e non credenti. Ma una cosa è soffrire senza sapere a che scopo, e un’altra soffrire sapendo che “le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi” (Rom 8, 18).
Rendere ragione della speranza
La speranza teologale ha un ruolo importante da svolgere nei confronti della evangelizzazione. Uno dei fattori determinanti del rapido diffondersi della fede, nei primordi del cristianesimo, fu l’annuncio cristiano di una vita dopo la morte infinitamente più piena e più gioiosa di quella terrena.
L’imperatore Adriano si era costruito in varie parti del mondo ville spettacolari e si era preparato come mausoleo quello che è ora Castel Sant’Angelo, a due passi da qui. Vicino alla morte scrisse una specie di epitaffio per la sua tomba. Parlando alla sua anima, la esortava, in esso, a dare un ultimo sguardo alle bellezze e agli svaghi di questo mondo, perché –diceva – stai per scendere “in luoghi incolori, ardui e spogli” . L’Ade! Si può immaginare lo shock spirituale che doveva provocare, in un’atmosfera come questa, l’annuncio di una vita infinitamente più piena e più luminosa di quella che si lasciava con la morte. Si spiega così perché l’idea e i simboli della vita eterna sono tanto frequenti nelle sepolture cristiane delle catacombe.
Nella Prima lettera di san Pietro, l’attività della Chiesa all’esterno, cioè la propagazione del messaggio, è presentata come un “rendere ragione della speranza”: “Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”. (1Pt 3, 15-16). Leggendo i racconti successivi alla Pasqua, si ha la sensazione che la Chiesa nasce da un moto di “speranza viva” (1Pt 1,3) e con questa speranza mossero alla conquista del mondo:
Anche oggi abbiamo bisogno di una rigenerazione della speranza se vogliamo intraprendere una nuova evangelizzazione. Non si fa nulla senza speranza. Gli uomini vanno là dove si respira aria di speranza e fuggono dove non avvertono la presenza di essa. La speranza è quella che dà il coraggio ai giovani di formarsi una famiglia o di seguire una vocazione religiosa e sacerdotale, che li tiene lontani dalla droga e da altri simili cedimenti alla disperazione.
La lettera agli Ebrei paragona la speranza a un’àncora: “In essa abbiamo come un’àncora della nostra vita, sicura e salda” (Eb 6, 18-19). Sicura e salda perché gettata nell’eternità. Ma abbiamo anche un’altra immagine della speranza,in certo senso opposta: la vela. Se l’àncora è ciò che dà alla barca la sicurezza e la tiene ferma tra l’ondeggiare del mare, la vela è invece ciò che la fa camminare, e avanzare nel mare. Entrambe queste cose fa la speranza con la barca della Chiesa.
Rispetto al passato, noi siamo oggi in una situazione di vantaggio nei confronti della speranza. Non dobbiamo più passare il nostro tempo a difendere la speranza cristiana dagli attacchi esterni; possiamo quindi fare la cosa più utile e fruttuosa che è quella di proclamarla, di offrirla e di irradiarla nel mondo. Fare della speranza un discorso non tanto apologetico, quanto piuttosto kerigmatico.
Diamo uno sguardo a cosa è successo a proposito della speranza cristiana da oltre un secolo a questa parte. Dapprima c’è stato l’attacco frontale contro di essa da parte di uomini come Feuerbach, Marx, Nietzsche. La speranza cristiana è stata, in molti casi, l’obiettivo diretto della loro critica. Vita eterna, aldilà, paradiso: tutte queste cose venivano viste come la proiezione illusoria dei desideri e bisogni inappagati dell’uomo in questo mondo, come uno “sprecare in cielo i tesori destinati alla terra”. I cristiani cercavano di difendere il contenuto della speranza cristiana, spesso con malcelato disagio. La speranza cristiana era “in minoranza”. Si parlava e si predicava raramente di vita eterna.
Se non che dopo aver demolito la speranza cristiana, la cultura atea marxista non tardò ad accorgersi che non si potevano lasciare le persone umane senza speranza. Ed ecco che inventò il “Principio speranza” . Con esso la cultura marxista non pretendeva di aver demolito la speranza cristiana, ma, peggio, di essere andato al di là di essa e di esserne il legittimo erede. Per l’autore del “Principio speranza” (principio, si badi bene, non virtù) è certo che la speranza è vitale per l’uomo. Essa è reale e ha uno sbocco che è “la rivelazione dell’uomo nascosto”, cioè delle possibilità ancora latenti dell’umanità. La manifestazione del Figlio dell’uomo, Cristo, è sostituita dalla manifestazione dell’uomo nascosto, la parusia è rimpiazzata dall’utopia.
Per un paio di decenni, ricordo, non si parlava d’altro nelle università e a molti cristiani non pareva vero che ci fosse qualcuno, dall’altra sponda, che accettava di prendere sul serio la speranza e di instaurare un dialogo. Tanto più che il rovesciamento era così sottile e il linguaggio spesso simile. La patria celeste diveniva la “patria dell’identità”; non il posto dove l’uomo vede finalmente, faccia a faccia, Dio, ma dove vede il vero uomo, nel quale si ha ormai l’identità perfetta tra ciò che può essere e ciò che è. La cosiddetta “teologia della speranza” è nata in risposta a questa sfida, accettandone, purtroppo, a volte, l’impostazione. La cosa che meno si avverte in tutti questi scritti è proprio quello che Pietro chiama la “speranza viva” (1 Pt ,1,3), il fremito della speranza. Non vita, ma ideologia.
Ora, dicevo, la situazione in parte è cambiata. Il compito che abbiamo davanti, nei confronti della speranza, non è più quello di difenderla e di giustificarla filosoficamente e teologicamente, ma di annunciarla, di mostrarla e di donarla a un mondo che ha perso il senso della speranza e sprofonda sempre più in un pessimismo e nichilismo che è il vero “buco nero” dell’universo.
Gaudium et spes
Un modo di rendere attiva e contagiosa la speranza è quello formulato da san Paolo quando dice che “la carità tutto spera” (1 Cor 13,7). Questo vale non solo per la singola persona, ma anche per l’insieme della Chiesa. La Chiesa tutto spera, tutto crede, tutto sopporta. Essa non può limitarsi a denunciare le possibilità di male che ci sono nel mondo e nella società. Non si deve certamente trascurare il timore del castigo e dell’inferno e cessare dal mettere in guardia le persone dalle possibilità di male che un’azione o una situazione comporta, come le ferite arrecate all’ambiente. L’esperienza però dimostra che si ottiene di più per via positiva, insistendo sulle possibilità di bene; in termini evangelici, predicando la misericordia. Mai forse il mondo moderno si è mostrato così ben disposto verso la Chiesa e così interessato al suo messaggio, come negli anni del Concilio. E il motivo principale è che il Concilio dava speranza.
Ma in questo modo, non ci si espone – si dice – ad essere delusi e a sembrare ingenui? Questa è la grande tentazione contro la speranza, suggerita dalla prudenza umana, o dalla paura di essere smentiti dai fatti ed è quello che sta capitando in parte anche nei confronti del Concilio. Come se l’aver osato parlare di “gioia e speranza” (gaudium et spes) fosse stata un’ingenuità di cui ci si debba perfino un po’ vergognare. È quello che molti pensarono di Papa Giovanni al suo annuncio del Concilio.
Dobbiamo riprendere il moto di speranza avviato dal Concilio. L’eternità è una misura molto larga; ci permette di sperare di tutti, di non abbandonare nessuno senza speranza. L’Apostolo dava ai cristiani di Roma la consegna di abbondare nella speranza. “Il Dio della speranza -scriveva – vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo (Rom 15, 13).
La Chiesa non può fare al mondo dono migliore che dargli speranza, non speranze umane, effimere, economiche o politiche, sulle quali essa non ha competenza specifica, ma speranza pura e semplice, quella che anche, senza saperlo, ha per orizzonte l’eternità e per garante Gesù Cristo e la sua resurrezione. Sarà poi questa speranza teologale a fare da molla a tutte le altre legittime speranze umane. Chi ha visto un medico visitare un ammalato grave, sa che il sollievo più grande che gli può procurare, migliore di tutte le medicine, è dirgli: “Il medico spera; ha buone speranze per te!”.
La speranza, così intesa, trasforma tutto ciò che tocca. Il suo effetto è descritto meravigliosamente in questo brano di Isaia:
Anche i giovani faticano e si stancano,
gli adulti inciampano e cadono;
ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza,
mettono ali come aquile,
corrono senza affannarsi,
camminano senza stancarsi (Is 40, 30-31).
Dio non promette di togliere i motivi di stanchezza e di spossatezza, ma dona speranza. La situazione resta in sé quella che era, ma la speranza dà la forza di elevarsi al di sopra di essa. Nell’Apocalisse si legge che “quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei” (Ap 12, 13-14). L’immagine delle ali dell’aquila si ispira chiaramente al testo di Isaia. Si viene perciò a dire che alla Chiesa intera sono state date le grandi ali della speranza, perché con esse possa, ogni volta, sfuggire agli attacchi del male, superare di slancio le difficoltà.
“Alzati e cammina!”
La porta del tempio detta “la Bella” è nota per il miracolo che avvenne presso di essa. Uno storpio giaceva davanti ad essa per chiedere l’elemosina. Un giorno passarono di lì Pietro e Giovanni e sappiamo cosa accadde. Lo storpio, guarito, balzò in piedi e finalmente dopo chissà quanti anni che giaceva lì abbandonato, varcò anche lui quella porta ed entrò nel tempio, si legge, “saltando e lodando Dio” (At 3, 1-9).
Qualcosa del genere potrebbe capitare anche a noi nei confronti della speranza. Anche noi ci troviamo spesso, spiritualmente, nella posizione dello storpio sulla soglia del tempio: inerti, tiepidi, come paralizzati davanti alle difficoltà. Ma ecco che la divina speranza ci passa accanto, portata dalla parola di Dio, e dice anche a noi, come Pietro allo storpio: “Alzati e cammina!” E noi balziamo in piedi e entriamo finalmente dentro, nel vivo della Chiesa, pronti ad assumerci, di nuovo e gioiosamente, compiti e responsabilità. Sono i miracoli quotidiani della speranza. Essa è davvero una grande taumaturga, una grande operatrice di miracoli; rimette in piedi migliaia di storpi, migliaia di volte.
Oltre che per l’evangelizzazione, la speranza ci è di aiuto nel nostro cammino personale di santificazione. Essa diviene, in chi la esercita, il principio del progresso spirituale. Permette di scoprire sempre nuove “possibilità di bene”, sempre qualcosa che si può fare. Non lascia che ci si adagi nella tiepidezza e nell’accidia. Quando sei tentato di dire a te stesso: “Non c’è più nulla da fare”, ecco che la speranza si fa avanti e ti dice: “Prega!”. Tu rispondi: “Ma ho pregato!” ed essa: “Prega ancora!”. E anche quando la situazione dovesse diventare dura all’estremo e tale da sembrare che non c’è proprio più nulla da fare, ecco che la speranza ti addita ancora un compito: sopportare fino alla fine e non perdere la pazienza, unendoti a Cristo sulla croce. L’Apostolo, abbiamo sentito, raccomanda di “abbondare nella speranza”, ma aggiunge subito come questo diventa possibile: “per virtù dello Spirito Santo”. Non per i nostri sforzi.
Il Natale può essere l’occasione per un sussulto di speranza. Il grande poeta moderno delle virtù teologali, Charles Péguy, ha scritto che Fede, Speranza e Carità sono tre sorelle, due grandi e una piccina. Vanno per la strada tenendosi per mano: le due grandi, Fede e Carità, ai lati e la bambina Speranza al centro. Tutti, vedendole, pensano che sono le due grandi che trascinano la piccina al centro. Si sbagliano! È lei che trascina tutto . Perché se viene a mancare la speranza, tutto si ferma.
Se vogliamo dare un nome proprio a questa bambina, non possiamo che chiamarla Maria, colei che quaggiù – dice l’altro grande poeta delle virtù teologali, Dante Alighieri – “intra i mortali”, è “di speranza fontana vivace” .